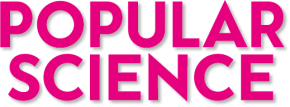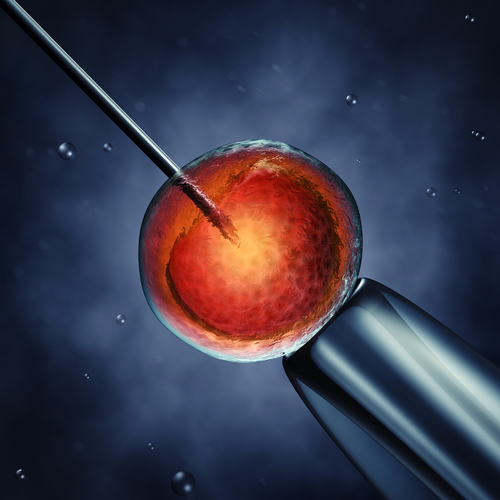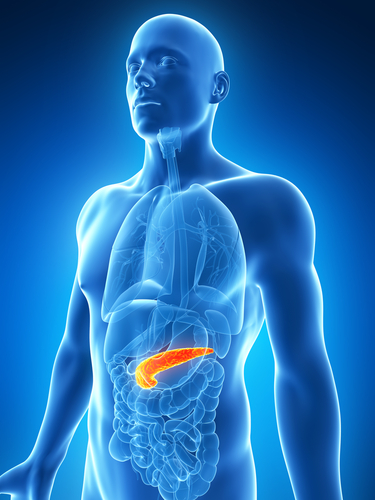“Stiamo osservando un cambiamento nell’ambiente intorno a Voyager 2”, ha spiegato uno dei responsabili del progetto Voyager, Ed Stone, del California Institute of Technology (Caltech) di Pasadena. Per l’esperto, però, “la sonda non ha ancora raggiunto la cosiddetta eliopausa”, che segna il confine del Sistema Solare. Ma come si fa ad assegnare un confine al nostro sistema planetario? La risposta viaggia nel vento solare, un flusso di particelle cariche che sulla Terra disegnano spettacolari aurore polari e nello spazio plasmano un’invisibile bolla che ci separa dal resto del cosmo. Un confine fluttuante, che si muove avanti e indietro come le onde del mare, a causa dell’attività ciclica del Sole con un minimo e un massimo ogni 11 anni circa.
Secondo le teorie attuali, al confine del nostro sistema planetario il vento solare rallenta fino a fermarsi, bilanciato dalla radiazione delle stelle della Via Lattea. Voyager 2 si trova tra questi flutti, come dimostra l’eccesso di raggi cosmici captato dai sistemi di bordo, ancora in funzione malgrado siano basati sull’elettronica a transistor di 40 anni fa.
Lanciate nel 1977, le sonde Voyager hanno fatto una sorta di Grand Tour del Sistema Solare, visitando i 4 pianeti più esterni: Giove, Saturno, Urano e Nettuno e alcune delle loro lune. Hanno, ad esempio, scoperto che anche Giove ha anelli, ma più rarefatti di quelli di Saturno. Hanno rivelato per la prima volta la presenza di attività vulcanica su un corpo celeste diverso dalla Terra, la luna gioviana Io. E hanno osservato per la prima volta le piogge di metano su Titano, luna di Saturno. Le sonde hanno inoltre a bordo un disco di rame dorato, simile ai vecchi 33 giri, su cui sono incisi suoni e immagini della Terra. Un messaggio in bottiglia cosmico, che fa delle Voyager autentiche ambasciatrici dell’umanità nell’universo.