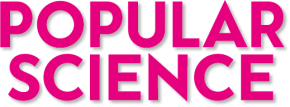Secondo appuntamento con “Incredibile”, il format ideato da Sics con il contributo non condizionante di Ipsen, dedicato ad approfondire la colestasi intraepatica progressiva familiare (PFIC), con una puntata interamente incentrata sul paziente adulto.
In apertura, il dr. Giovanni Vitale, dirigente medico presso la medicina interna per il trattamento delle gravi insufficienze d’organo dell’IRCCS Azienda ospedaliera Universitaria di Bologna, ha approfondito quali sono le principali differenze genetiche fisiologiche tra la forma che insorge nell’infanzia e quella che si manifesta in età adulta. La dr.ssa Laura Cristoferi, dirigente medico presso la gastroenterologia della Fondazione IRCCS San Gerardo tintore di Monza, ha parlato di come queste differenze influenzano la presentazione clinica e quali sono i sintomi più comuni nei pazienti adulti rispetto ai pazienti pediatrici. Il prof. Vincenzo Cardinale, professore associato presso il Dipartimento di Medicina traslazionale e di precisione della Sapienza Università di Roma, ha invece parlato di quali sono le principali sfide che lo specialista deve affrontare nella pratica clinica in termini di diagnosi di PFIC nell’adulto.
“Nelle nuove linee guida del 2022 – spiega la dr.ssa Cristoferi – viene suggerita negli adulti l’esecuzione del test genetico quando sono escluse altre patologie o nel forte sospetto clinico di una forma genetica, soprattutto nei pazienti giovani, intorno ai 40 anni come cut-off, o, se non più giovani, che hanno avuto un esordio dei sintomi in giovane età. L’esordio in giovane età dei sintomi ci aiuta e ci suggerisce una potenziale diagnosi di colestasi genetica, accompagnato anche dalla storia personale stessa del paziente, se ha avuto episodi di ittero neonatale, se ha avuto una colestasi gravidica e soprattutto la presenza del prurito, che è molto caratteristico sia all’esordio ma soprattutto diventa presente in quasi tutti i pazienti nel successivo follow up di malattia”.
“Elementi che sono praticamente automatici nell’algoritmo diagnostico nel bambino – aggiunge il dr. Vitale – non lo sono nell’adulto. Non c’è nessun studio prospettico che ci permetta di capire se acidi biliari aumentati possano orientare verso un determinato iter diagnostico, a prescindere dal fatto che ci possano essere tutti quegli elementi assolutamente utili di storia familiare o personale, di sospetto verso una forma di colestasi”.
Esistono delle sottopopolazioni con una più alta prevalenza di PFIC a cui prestare più attenzione dal punto di vista diagnostico? Secondo il prof. Cardinale “E’ veramente importante identificare quelle Red Flags che nella nostra pratica clinica sono fondamentali proprio per scoprire pazienti portatori di alterazioni genetiche. Ad esempio, è da considerare la predisposizione genetica nelle donne che hanno avuto una colestasi gravidica e una recidiva della condizione clinica alla seconda gravidanza, oppure nelle donne che hanno un esordio precoce, non solo nel terzo trimestre, come normalmente succede, ma anche nel secondo o addirittura nel primo trimestre di gravidanza, con una presentazione clinica particolarmente importante”.
Come è cambiata, negli ultimi anni, la gestione di questa patologia negli adulti alla luce del nuovo scenario terapeutico? Gli esperti sono apparsi concordi nell’affermare che è stata significativamente migliorata la terapia delle forme progressive dei bambini, che prima venivano inevitabilmente sottoposti a trapianti: le nuove terapie hanno allungato tantissimo la loro aspettativa di vita e migliorato la qualità di vita loro e dei genitori. Pur non sapendo ancora che prospettive avranno questi pazienti in futuro, essendo pazienti che questi specialisti si troveranno a gestire negli ambulatori tra qualche anno, le aspettative sono molto alte, anche alla luce dell’esperienza che ogni esperto si sta intanto costruendo sul camponel gestire la malattia con il supporto di nuove armi terapeutiche.