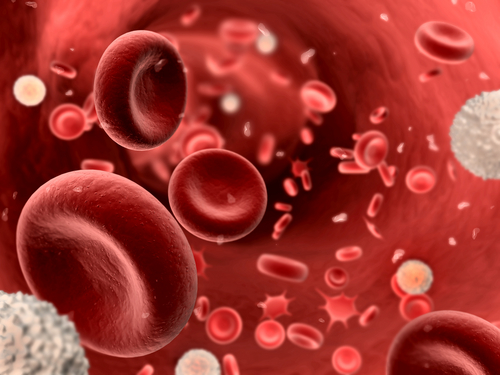Circa 10 milioni nel mondo; tra i sei e i dieci mila in Italia. Queste le persone che, ad oggi, convivono con una infezione da epatite Delta. Ma stiamo parlando solo di stime perché, per questa patologia, il sommerso è ancora molto elevato e non sempre vengono fatti test adeguati. Di questo e di come combattere l’infezione da HDV, grazie anche alla disponibilità di una terapia mirata, si è parlato in un simposio realizzato con il contributo non condizionane di Gilead dal titolo “Innovazione nel trattamento dell’HDV, la meno conosciuta, ma la più aggressiva tra le epatiti virali” in occasione del XLIV Congresso della Società Italiana di Farmacisti Ospedalieri (Sifo9, conclusosi domenica 8 ottobre a Roma.
L’epatite Delta, nella sua forma cronica, è la più aggressiva tra tutte le epatiti virali proprio per la sua rapida progressione con un più alto rischio di sviluppare cirrosi e tumore al fegato. Il virus dell’epatite Delta viene considerato un “virus satellite” perché per infettare le cellule epatiche ha necessariamente bisogno di un altro virus, detto helper, che è quello dell’epatite B. L’infezione da HDV si manifesta dunque solamente in presenza di una epatite B e due sono gli scenari possibili: coinfezione e superinfezione. Se l’infezione dei due virus è simultanea l’organismo è in grado di eliminarli entrambi nella maggioranza dei casi. Più grave è, invece, la superinfezione perché “quando c’è una epatite B cronica di base su cui poi si aggiunge una infezione da virus dell’epatite Delta, l’infezione da virus dell’epatite Delta diventa cronica e abbiamo una condizione estremamente pericolosa per il paziente perché accelera la progressione della malattia epatica verso la cirrosi e lo scompenso e aumenta di 9 volte il rischio di sviluppare un cancro del fegato”, ha ricordato Anna Maria Geretti della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Dal punto di vista epidemiologico, Geretti ha ricordato che siamo in presenza di una forbice molto ampia a causa del sommerso e della difficoltà a reperire dati specifici sulla epatite Delta essendo questa sempre legata alle B. Stiamo parlando di un numero compreso tra “i 9 e i 19 milioni di persone al mondo che hanno avuto un’esposizione al virus dell’epatite Delta”. Per l’Italia di stima che “circa 3-9% dei pazienti con epatite B cronica abbia anche un’epatite Delta” in fase avanzata di malattia perché in presenza di cirrosi.
Una riflessione sui trattamenti, per quanto riguarda questa patologie, è d’obbligo perché fino al 2020, data di approvazione EMA di bulevirtide, primo farmaco specifico, l’epatite Delta cronica non poteva beneficiare di una terapia mirata. Da quest’anno il farmaco è rimborsato anche in Italia e l’Aifa ha concesso l’attribuzione del requisito di innovatività terapeutica condizionata, che ne prevede l’inserimento negli elenchi dei farmaci innovativi. Come spiegato da Geretti, questo è un farmaco importante perché “agisce come antivirale nel bloccare l’ingresso del virus dell’epatite Delta all’interno delle cellule del fegato” e quindi impedisce la diffusione dell’infezione. Nello specifico “questa azione di blocco si traduce in una risposta virologica, quindi in un abbassamento della carica virale, e in un beneficio clinico con riduzione dell’infiammazione epatica. Dopo 96 settimane di trattamento, il 55% dei pazienti trattati ha un miglioramento sia dal punto di vista virologico che dal punto di vista biochimico e le risposte continuano ad aumentare mentre si continua il trattamento”. Al momento dunque “questa è un’opzione terapeutica efficace nel trattamento cronico, ma aspettiamo dati dagli studi in corso per capire se il trattamento possa diventare curativo piuttosto che un trattamento cronico”.
Per combattere l’epatite Delta la partita si gioca su screening, terapie innovative e nuovi percorsi assistenziali. L’introduzione in commercio di bulevirtide può fare la differenza non solo in termini di qualità di vita dei pazienti, ma anche per quanto riguarda i costi. Come spiegato da Andrea Marcellusi, ricercatore della facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, da uno studio realizzato dal centro di ricerca CEIS dell’Università è emerso che “a fronte di circa 2.000 pazienti diagnosticati e trattati oggi in Italia, che hanno un costo totale di 37 milioni di euro, grazie all’introduzione di bulevirtide si può arrivare ad una riduzione di circa il 10% della spesa”, in termini di costi sia diretti sia indiretti. E ancora, dall’analisi è emerso anche che l’introduzione di questa innovazione terapeutica ha un impatto anche sulla mortalità facendo registrare “una riduzione di 171 morti in 10 anni”.
Questi dati vanni analizzati in un’ottica più ampia. “È importante dire”, ha specificato Francesco Saverio Mennini, Direttore del CEIS dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, “che a livello di costi totali che caratterizzano questa patologia, più del 50% sono costi diretti sanitari. Al loro interno la fanno da padrone i costi dell’assistenza ospedaliera per un ammontare che è prossimo a circa 14 milioni di euro ogni anno, con una spesa media ospedaliera per paziente di circa 9.000 euro”. Si parla dunque, ha proseguito Mennini, di un impatto molto alto soprattutto se paragonato anche ad altre patologie più attenzionate di questa, e “questo ci porta a ragionare sul fatto che bisogna migliorare la diagnosi precoce, bisogna migliorare la presa in carico dei pazienti e, soprattutto, laddove esistono delle terapie più efficaci rispetto allo status quo, bisognerebbe anche cercare di far sì che i pazienti possano accedere a queste terapie più efficaci”.
Di questo ne è fermamente convinta anche Micaela Spatarella, Responsabile dell’UOSD di Farmacovigilanza dell’Ospedale Cotugno che ha aggiunto come in questo contesto, come in tutti gli altri in cui viene introdotta una terapia innovativa, il ruolo del farmacista ospedaliero sia fondamentale per migliorare la compliance del paziente. “Nel caso specifico – ha ricordato Spatarella – parliamo di un farmaco che va in autosomministrazione per cui il farmacista ha il ruolo di poter spiegare e aiutare il paziente per quanto riguarda la direzione e la preparazione della fiala e questo è importante perché il paziente dovrà sostenere la terapia al proprio domicilio”.