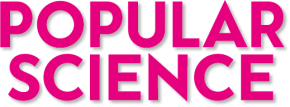In uno studio pubblicato di recente dalla rivista ESMO Open, i ricercatori di diversi centri in Italia hanno messo a punto e valutato l’efficacia di test accademici per il rilevamento del deficit di ricombinazione omologa nelle donne con carcinoma ovarico. L’uso di test genetici e funzionali potrebbe portare a un’identificazione più precisa, semplice ed economica delle pazienti che possono beneficiare dei farmaci PARP inibitori, come ci spiega l’autore dell’articolo Sandro Pignata, Direttore dell’UOC di di Oncologia Uro-Ginecologica dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale, Napoli
Perché è importante rilevare la presenza di un deficit della ricombinazione omologa nella pazienti con carcinoma ovarico?
Negli ultimi anni è stato scoperto che circa il 50% delle donne affette da tumore ovarico di alto grado presenta un deficit del sistema della ricombinazione omologa (attraverso cui la cellula ripara i danni al Dna). Le cellule delle pazienti con questo deficit, che in molti casi è legato a mutazioni nei geni BRCA 1 e 2 ma non sempre, hanno una difficoltà a riparare il Dna e quindi sono più suscettibili all’effetto letale della chemioterapia e dei PARP inibitori.
Uno studio recente ha dimostrato che solo le pazienti con deficit di ricombinazione omologa beneficiano di una terapia di combinazione di un PARP inibitore con bevacizumab.
Quali test vengono usati per identificare il deficit?
Negli studi di solito si usa un test commerciale, MyChoice CDx (Myriad), che presenta però dei limiti. È molto costoso e nel 20% dei casi non offre un risultato valido. Il numero dei test commerciali sta aumentando, ma nessuno di questi è disponibile sul territorio nazionale perché non sono rimborsabili.
Come è possibile allora effettuare il test?
La questione della rimborsabilità è di grande attualità, se ne discute. E si stanno sviluppando delle modalità alternative (con test più economici e più semplici da effettuare) per fare la valutazione della ricombinazione omologa al livello di singoli ospedali o di più ospedali, che possono funzionare da hub per l’intero Paese.
Parliamo dei vostri test, in cosa consistono?
Noi abbiamo prodotto dei test, che chiamiamo accademici poiché sono stati sviluppati all’interno di un consorzio di ricerca, del gruppo MITO e del gruppo MaNGO, e abbiamo dimostrato nel nostro studio che con due modalità differenti siamo in grado di riprodurre il risultato del test commerciale in modo molto affidabile.
Lo studio in questione è poi andato oltre: abbiamo messo a punto altri test, non genomici, per l’identificazione delle alterazioni funzionali del pathway della ricombinazione omologa. In particolare abbiamo provato un test che si basa sulla ricerca del fattore RAD51, molto importante per questa via. Ritentiamo che in futuro sarà necessario incrociare un test genomico e un test funzionale per definire con maggiore precisione quali sono le pazienti che possono beneficiare dei PARP inibitori.
Come mai avete scelto proprio RAD51?
Ci siamo concentrati su questa proteina perché le alterazioni di RAD51, indipendentemente dalle mutazioni che ci sono a monte, possono rendere il pathway attivo o inattivo. Quindi, anche in presenza di mutazioni genetiche, valutando se le alterazioni a valle di RAD51 determinano un funzionamento o malfunzionamento del pathway, aggiungiamo un’informazione ulteriore.
Come funzionano i test che avete messo a punto?
I due test genomici accademici che sono stati confrontati con il test commerciale si basano sulla stessa idea, che in presenza di mutazioni genetiche o di alterazioni epigenetiche, sia possibile evidenziare a livello del Dna delle specie di “cicatrici”, che indicano che la cellula non è capace di riparare il Dna. I due test genomici usano tecnologie differenti ma riproducono lo stesso principio: la ricerca di queste cicatrici. E poi abbiamo aggiunto il test di RAD51 che valuta se, anche in presenza di mutazioni genetiche, ci sono delle alterazioni a valle. Per fare questo RAD51 viene identificata ricercando con l’immunoistochimica la presenza di foci di aggregazione della proteina e questo ci dice se il pathway è attivo o non attivo.
Quali prospettive si aprono nella pratica clinica della gestione del carcinoma ovarico anche grazie ai vostri risultati?
Grazie ai nostri test e ad altri test accademici messi a punto dai ricercatori, nella pratica clinica verranno a breve usati dei test più semplici ed economici dei test commerciali. La prospettiva del nostro studio, che però richiede conferme di efficacia in una coorte più numerosa di soggetti, è la possibilità di combinare un test genomico e un test funzionale per una migliore identificazione delle pazienti che possono meglio rispondere ai PARP inibitori. Questi studi mostrano l’importanza della ricerca accademica e dei network che mettono in comunicazione centri clinici, laboratori italiani e i centri internazionali.
ESMO Open. 2022 Oct;7(5):100585. doi: 10.1016/j.esmoop.2022.100585.