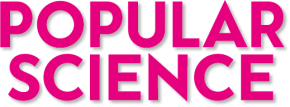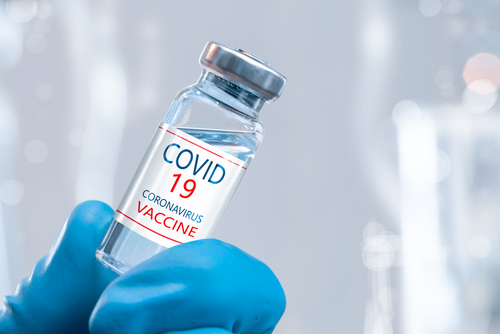I risultati di questo studio internazionale sono stati presentati in occasione del Congresso dell’Associazione europea di ematologia (Eha) a Madrid, studio questo selezionato tra i sei migliori lavori pervenuti e che si è aggiudicato anche una particolare menzione dall’Eha. “Lo studio – spiega Algeri – ha coinvolto 98 pazienti in Usa ed Europa con un’età media tra 4 e 8 anni; il paziente più piccolo ha 3 mesi e il più grande 18 anni”.
Si tratta di un passo avanti significativo, e le ragioni sono semplici: “Fino a pochi anni fa – chiarisce l’esperto – il trapianto di staminali in questi bambini era possibile solo a patto che il donatore fosse compatibile. Successivamente è arrivato il trapianto da donatore parzialmente compatibile, ovvero i genitori, nel quale si trapiantano solo le staminali eliminando i linfociti non compatibili. Con tale tecnica, però, è alto il rischio che il bambino sviluppi uno stato di immunodeficienza con il pericolo di contrarre infezioni serie”.
Da qui la svolta resa possibile con la metodica del ‘gene suicida’: “Il nostro approccio – precisa Algeri – prevede una selezione dei linfociti dal donatore prima che avvenga il trapianto; i linfociti prelevati vengono quindi geneticamente modificati con un gene definito ‘suicida’. Si tratta del gene della caspasi 9, che permette di ‘spegnere’ i linfociti nel momento in cui dovessero determinare reazioni avverse nel paziente trapiantato”. A questo punto, i linfociti modificati vengono infusi nei piccoli pazienti a distanza di due settimane dal trapianto di staminali; “Se nel tempo provocano reazioni negative, ai pazienti viene somministrata una particolare e nuova molecola, rimiducid, che spinge i linfociti dotati del gene ‘suicida’ all’autoeliminazione”.
Questo metodo, prosegue l’esperto, “ha l’obiettivo di accelerare la ricostituzione della risposta immunologica nei piccoli pazienti dopo il trapianto, ma rende possibile ‘spegnere’ i linfociti in caso di danni. Così il bambino non ha una reazione avversa al trapianto, e avendo già innescato la produzione di propri linfociti non resta scoperto”.
Più che positivi i risultati dello studio: “A 6 mesi di follow-up, la mortalità per cause legate al trapianto è stata pari a zero nei 61 pazienti europei e pari al 5% sul totale di 98 pazienti”. Un metodo innovativo, e per questo premiato dal congresso degli ematologi europei, che “migliora la sicurezza e l’efficacia dei trapianti di staminali per i pazienti pediatrici. Ora – afferma Algeri – l’obiettivo è verificare l’efficacia dei linfociti modificati anche nel prevenire le ricadute da leucemia”. Particolarmente soddisfatto il ricercatore, da 2 anni al Bambino Gesù e contento di lavorare in Italia: “E’ un riconoscimento anche alla ricerca italiana e, soprattutto – conclude – una buona notizia per i pazienti”.