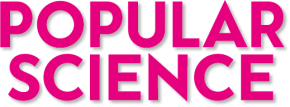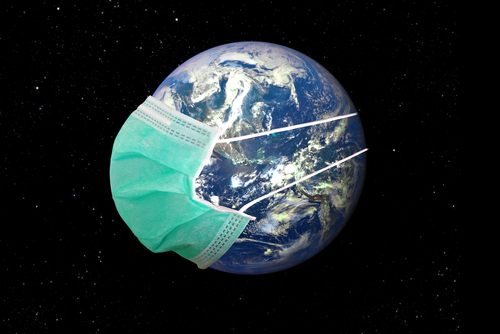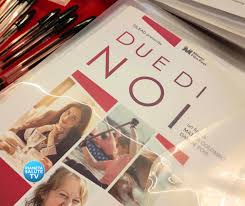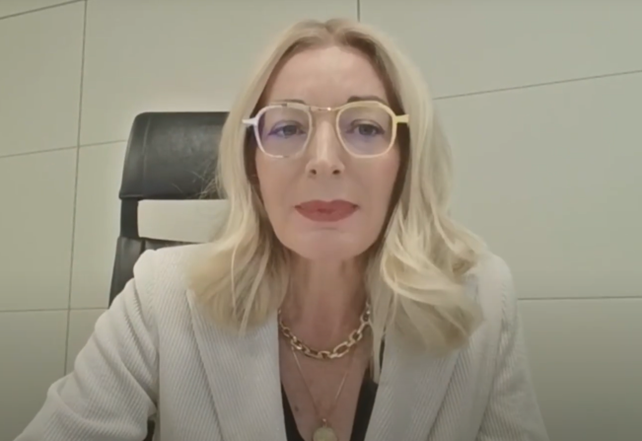A vent’anni dall’entrata in vigore della legge 219, bilancio è positivo: il sistema trasfusionale italiano è cresciuto, ha consolidato i principi che ne garantiscono la sostenibilità e ha saputo mantenere una forte identità pubblica e solidale. Tuttavia, le differenze tra Regioni, la carenza di personale e la necessità di rafforzare la raccolta di plasma restano sfide ancora aperte. Questa l’istantanea scattata da Pierluigi Berti. Responsabile della SRC (struttura regionale di coordinamento) Valle d’Aosta, che individua nella legge 219 un momento di svolta per il settore, ma anche l’origine di alcune criticità che ancora oggi pesano sull’organizzazione complessiva.
Un sistema più autonomo ma anche più frammentato Con la legge 219, spiega Berti, il sistema trasfusionale ha ricevuto un impulso decisivo. La normativa ha chiarito ruoli e competenze, definendo i livelli di coordinamento sia centrale che periferico e creando così un modello più articolato e organizzato. Dopo la riforma del Titolo V, la legge ha inoltre risentito dell’impostazione “federalista” che ha caratterizzato il nuovo rapporto tra Stato e Regioni, dando a queste ultime maggiore autonomia gestionale e riducendo il peso di un controllo centrale troppo rigido.
Questo nuovo equilibrio ha favorito una crescita complessiva del sistema, ma al tempo stesso ha determinato un effetto collaterale importante: la nascita di 21 sistemi trasfusionali regionali differenti, con modelli organizzativi e risultati spesso molto diversi tra loro. La frammentazione e la disomogeneità, riconosce Berti, rappresentano ancora oggi uno dei principali limiti del sistema, pur in presenza di un evidente progresso complessivo.
Accordi interregionali e compensazione: un modello che funziona Uno dei punti di forza del sistema trasfusionale italiano è rappresentato dal meccanismo degli accordi interregionali e della compensazione del sangue e dei plasmaderivati, concepito per garantire equità nella distribuzione tra le diverse realtà territoriali. “Guardando ai risultati non si può che riconoscere che questi strumenti hanno funzionato – sottolinea Berti – da un lato, hanno permesso di mantenere al centro del sistema la sua natura pubblica, fondata sulla donazione volontaria, anonima e gratuita; dall’altro, hanno contribuito a far crescere in modo significativo la raccolta di plasma”.
Oggi l’Italia conferisce oltre 900.000 chili di plasma per la produzione di farmaci plasmaderivati, un risultato che consente di rispondere in maniera soddisfacente al fabbisogno nazionale. Tuttavia, permangono differenze regionali nella capacità di raccolta e nella risposta alla domanda di alcuni plasmaderivati, in particolare delle immunoglobuline endovena e sottocute.
Un aspetto positivo, sottolinea Berti, è la possibilità di scambio tra accordi interregionali con composizioni diverse del paniere di farmaci plasmaderivati, una pratica che ha contribuito a mantenere la coerenza del sistema e a valorizzare il principio fondante della donazione volontaria e non remunerata. Le associazioni di donatori, così come i donatori stessi, hanno avuto e continuano ad avere un ruolo attivo anche nella definizione e nella valutazione di questi accordi, contribuendo a preservare la natura etica del sistema.
Le differenze tra Regioni e il ruolo del Centro nazionale sangue La diversità dei modelli regionali si riflette anche sulla capacità di raccolta del plasma. Esistono Regioni più avanzate, che hanno saputo sviluppare in modo efficace la plasmaferesi e l’organizzazione territoriale, e altre che faticano ancora a raggiungere gli obiettivi fissati.
In questo quadro, il Centro nazionale sangue, evidenzia Berti, ha svolto negli ultimi anni un ruolo importante di stimolo e coordinamento, introducendo meccanismi di benchmarking tra le diverse Regioni. Questo confronto continuo tra realtà più forti e più deboli ha favorito una crescita complessiva, stimolando anche i territori meno performanti a migliorare la propria capacità di raccolta.
L’ultimo miglio verso l’autosufficienza Raggiungere l’autosufficienza per il plasma, obiettivo ancora più complesso rispetto a quello già centrato per il sangue, richiede, secondo Berti, interventi mirati e strutturali.
Le priorità individuate sono diverse: rafforzare il reclutamento di personale sanitario, sia medico che infermieristico, rendendo più attrattivo il sistema trasfusionale e favorendo il ricambio generazionale; consolidare il ruolo del Centro nazionale sangue, affidandogli la regia di piani nazionali per lo sviluppo della raccolta del plasma, da elaborare insieme alle Regioni e alle associazioni dei donatori; investire in campagne informative e di sensibilizzazione, per accrescere la consapevolezza pubblica sulla strategicità del sistema trasfusionale e dei farmaci plasmaderivati. E ancora, migliorare la comunicazione digitale e la circolazione delle informazioni tra i diversi sistemi regionali, promuovendo trasparenza e capacità di intervento rapido. In questa direzione si muove anche il nuovo sistema informativo nazionale (Sistri), pensato proprio per rendere più efficace lo scambio di dati e la gestione operativa.
Solo attraverso una comunicazione più fluida e un’organizzazione più integrata, spiega Berti, sarà possibile colmare le differenze e rendere il sistema davvero uniforme su tutto il territorio nazionale.
Donazione volontaria e associazioni: un patrimonio da preservare Berti ricorda infine l’importanza delle associazioni di donatori, che rappresentano un pilastro del sistema trasfusionale italiano. Oltre a garantire la continuità della raccolta, queste associazioni sono parte attiva nei processi decisionali e nella difesa dei valori fondanti del sistema: volontarietà, anonimato e gratuità del dono. “Questa dimensione etica e partecipativa – osserva Berti – resta il tratto distintivo del modello italiano e un valore da tutelare anche nel percorso verso una maggiore efficienza e autosufficienza”.
Un bilancio positivo, ma con margini di miglioramento In sintesi, conclude Berti, solo attraverso una visione unitaria, una maggiore integrazione digitale e un rinnovato impegno di tutte le componenti – istituzioni, professionisti e donatori – sarà possibile completare l’“ultimo miglio” verso la piena autosufficienza e garantire un sistema trasfusionale sempre più equo, efficiente e vicino ai cittadini.
E.M.