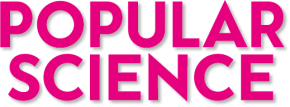La ricerca si basa sull’idea che l’analisi del clima passato, dell’ultimo periodo interglaciale (129-116 mila anni fa), possa fornire fondamentali indicazioni per capire le tendenze attuali e future. Come spiega Zanchetta l’ultimo periodo interglaciale è stato caratterizzato da un intenso riscaldamento artico, con temperature più alte di alcuni gradi rispetto a quelle attuali, paragonabili quindi agli scenari di riscaldamento previsti per la fine di questo secolo.
I ricercatori hanno stimato, come conseguenza, che il livello globale del mare in quell’epoca sia stato di circa 6-9 metri superiore al livello attuale, in buona parte a causa della fusione della calotta glaciale della Groenlandia. Ciò “potrebbe aver contribuito ad un’instabilità, della circolazione oceanica del Nord Atlantico, con momenti di indebolimento corrispondenti a periodi di scarsità di precipitazioni in Europa”.
“Sebbene l’ultimo periodo interglaciale non sia del tutto sovrapponibile a quanto accade oggi come conseguenza dell’attività umana – conclude Zanchetta – il profilo climatico che emerge, su scala secolare, indica che il progressivo riscaldamento che stiamo osservando possa generare in futuro un’instabilità del clima associata a fenomeni significativi di siccità”.
Per definire in dettaglio i cambiamenti oceanici e atmosferici dell’Atlantico settentrionale e dell’Europa meridionale, i ricercatori hanno prodotto una sorta di ‘stele di rosetta stratigrafica’, analizzando una carota di sedimento marino proveniente dal margine atlantico della penisola iberica e confrontandola con l’andamento delle precipitazioni registrato nelle stalagmiti della grotta Antro del Corchia, nel nord Italia, “vero e proprio archivio del clima passato”.