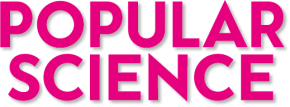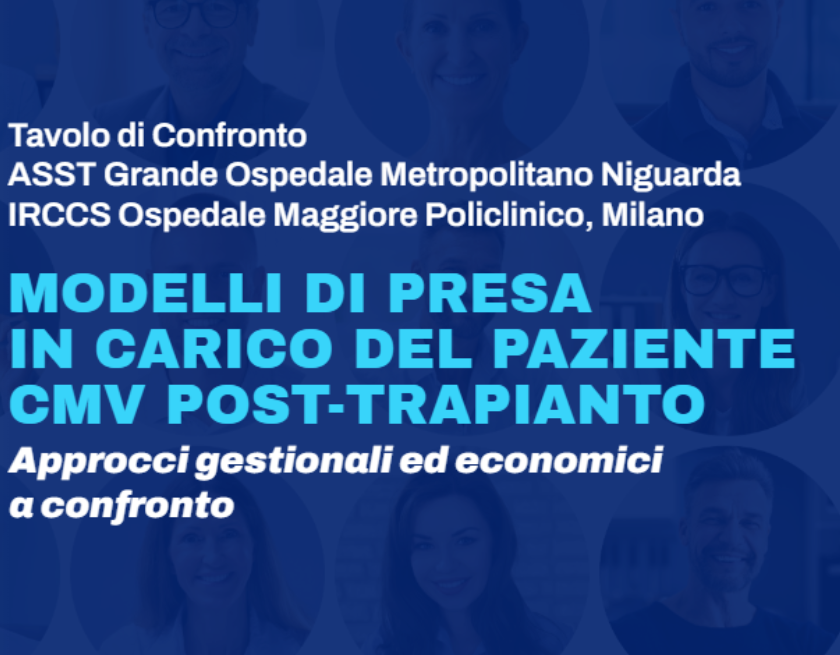L’identikit della propargil-immina è stato ricostruito nei laboratori del Max Planck e poi confrontato con i dati del radiotelescopio della Sierra Nevada, in Spagna. “La molecola era già lì, nei dati raccolti sulla nube molecolare G+0.693-0.027, stava solo aspettando che qualcuno la riconoscesse”, ha spiegato Rivilla, dell’Inaf di Firenze. “Non potevamo, però, esserne certi perché ci mancavano le informazioni precise sulle frequenze a cui emette fotoni, che abbiamo ottenuto grazie alle misure di laboratorio”, ha chiarito l’esperto.
“Quando una molecola gira o vibra nel mezzo interstellare emette, infatti, fotoni a delle frequenze molto precise che, dal confronto con i dati raccolti dai radiotelescopi, ci permettono di capire se una molecola è presente o meno nello spazio. E, in particolare, nelle nubi molecolari che in futuro formeranno nuove stelle e sistemi planetari. La collaborazione tra laboratorio e osservazioni – ha concluso Rivilla – è fondamentale per scoprire nello spazio nuove molecole, importanti per innescare la chimica che ha portato sulla Terra alla vita come la conosciamo oggi”.